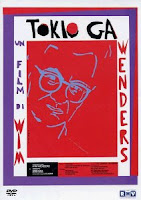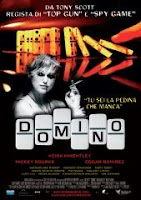Per me è arrivato. Finalmente sono riuscita a vedere il nuovo di Shyamalan, “The happening” (“E venne il giorno” è la solita odiosa traduzione italiana).
Avendone sentito parlare (da molti) piuttosto male, come sempre mi accade ero ancora più incuriosita. La prima impressione è stata che questo film fosse il compimento naturale di “The village” e di “Lady in the water”.
Il cineasta indiano - soprattutto in queste tre pellicole - ha ampiamente dimostrato il suo interesse per la comunità, per le masse di persone accomunate da qualcosa
che si trovano a dover affrontare, combattere e interpretare l’intrusione di un elemento esterno.
In “The happening” la comunità è costituita dall’intera popolazione umana e ciò che deve fronteggiare è una natura che, stanca dell’aggressione dell’uomo, si ribella portando lo sterminio.
Shyamalan descrive con grande ironia la ribellione di madre natura che in modo bizzarro e apparentemente metodico quanto non decodificabile da scienza, politica o sociologia, sembra aver deciso di distruggere il genere umano, partendo (e via a possibili spiegazioni da talk show) dal nord est degli States.
La cifra grottesca del film si incarna nel protagonista Elliot, docente di scienze che cerca in ogni modo una spiegazione e poi la salvezza per la sua famiglia, mentre il cardine dell’intero costrutto narrativo è senz’altro l’idea di falso.
Dunque Natura (naturale) versus Falso (manipolato oltre ogni limite dall’uomo).
Il Falso è presente in tutti i momenti di questa opera ecologista ed eco-logica. Il vento mortale parte sempre da un parco (Il parco per eccellenza Central Park all’inizio ma anche un parco di Parigi alla fine) che altro non è che il tentativo di impiantare un po’ di natura dentro una città che di naturale non ha nulla (quindi doppio falso); gli uomini quando vengono colpiti dal vento immobilizzatore restano pietrificati come statue (quindi finti uomini); la famiglia protagonista è in realtà una finta famiglia (la bambina non è loro figlia ma il surrogato di quella che non si decidono ad avere); per non parlare della scelta degli attori e dei personaggi (falsi) che paiono usciti da una fiction.
Tutto ciò - e molto altro - fa pensare però che la fine non sia poi così tragica, che forse una brezza mortale e distruttiva possa porre fine a un pianeta ormai insopportabilmente finto e consunto a favore della nascita di una nuova umanità (insomma, forse siamo proprio alla frutta).
C’è da pensarci. Prima che arrivi il giorno, possibilmente.